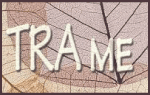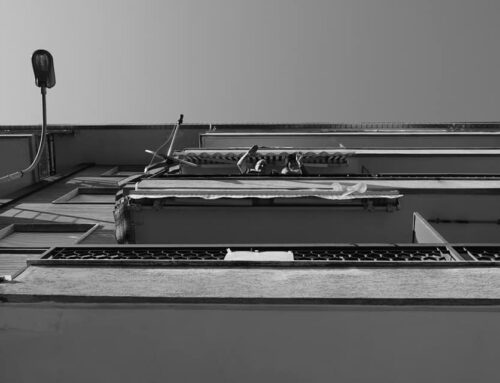Reportage. Le cliniche “svizzere”, per la loro efficienza e pulizia costruite da Emergency nei campi per i profughi iracheni e siriani si confrontano con bisogni urgenti ed enormi. La geografia rigorosa che distingue i “quartieri” sciiti da quelli sunniti e della minoranza yazida.
Si chiama Rebwar Ali Salih, ha 32 anni ed ha una gamba sola. Però passeggia su e giù, svelto svelto, con la sua protesi che va dal ginocchio in giù, in una sala del centro di riabilitazione di Emergency. E’ qui per una “messa a punto”, una specie di “tagliando”, insomma. Quelli che sono saltati in aria pestando mine anti-uomo e se la sono cavata con l’amputazione di uno o più arti sono davvero tanti, in tutto l’Iraq. E questo di Sulaymaniyah è l’unico luogo dove chi ha avuto esperienze del genere può rivolgersi, non solo per evitare di trascorrere la vita appesi alle stampelle, ma anche perché Emergency, dopo aver fornito gratuitamente gambe, braccia, piedi e mani artificiali, da’ a tutti anche l’occasione di imparare un mestiere e lavorare nel laboratorio dove si fabbrica ogni sorta di arto artificiale. “Ne sforniamo 40-45 al giorno dice Faris Hama, manager del centro – con un apporto direi decisivo di chi, nonostante sia mutilato, impara il mestiere di artigiano ortopedico in un paio di mesi al massimo”.
Il ricordo della strage di Halabja. La “semina” degli ordigni nascosti sul terreno – che si calcola siano ancora oltre 5 milioni, sparsi ovunque – c’è stata durante il regime di Saddam, che ai curdi ha riservato sempre “particolari” attenzioni. Indimenticata è la strage nella città di Halabja, il 16 marzo 1988, quando l’esercito iracheno usò gas al cianuro per eliminare in un solo colpo oltre 5 mila persone. Non fu altro che una rappresaglia contro la gente curda che – secondo il rais – s’era dimostrata poco tenace nel resistere al nemico iraniano. Il totale dei curdi morti in quella guerra con l’Iran furono oltre 100.000.
Ma oggi tutto questo sembra dimenticato. L’orgoglio radicato in mellenni di storia del popolo curdo, appare oggi più che mai un’arma micidiale, più del cianuro, che sembra vogliano spenderla qui, con maggior vigore, in quella che vorrebbero fosse la loro terra riconosciuta. Un orgoglio ostentato nell’accogliere, non solo i curdi minacciati dall’IS, sfuggiti agli attentati e alle fosse comuni nelle città ancora in mano ai taglia-gole, ma anche gli iracheni in fuga da Falluja o gli yazidi scappati da Sinjar, luoghi d’inferno occupati dal cosiddetto stato islamico. Orgogliosi ma consapevole che comunque la storia non ha ancora finito di chiedere loro sacrifici.
Successi militari e crisi economica. Ai successi militari dei Peshmerga curdi, in buona parte dovuto all’addestramento e agli armamenti italiani, fa infatti da contrappeso la pesante batosta subìta dall’economia del Kurdistan, legata soprattutto al petrolio – di cui esistono giacimenti ricchissimi – il cui prezzo è scivolato in un precipizio dal quale non si sa se e quando potrà risalire. Un colpo durissimo, a causa del quale – ad esempio – i dipendenti pubblici, compresi gli insegnanti delle scuole, non prendono lo stipendio da 5 mesi; oppure senti in giro racconti di chi ancora gode un certo benessere relativo e per questo si trova a prestare la corrente elettrica al vicino di casa, al quale l’hanno staccata, o hanno rubato il gruppo elettrogeno.
Orgogliosamente al sicuro all’ombra del grattacelo. Nonostante tutto però, la città curda – dove ci si sente orgogliosamente al sicuro, malgrado a distanza di un’ora di macchina le bandiere nere dello stato islamico continuino a sventolare e ad accompagnare battaglie sanguinose contro le milizie sciite iraniane, quelle degli yazidi, e contro l’esercito iracheno – piace ostentare lo skyline di un grattacelo che s’illumina di viola al tramonto e ricorda (forse non a caso) la sagoma di un’enorme vela, come quella dell’hotel Burj al-Arab di Dubai, ormai promosso a rango di simbolo di questa piccola metropoli, circondata da montagne brulle e battute da un vento impetuoso.
La geografia del campo. L’integrazione dei rifugiati interni iracheni in Kurdistan, non è, e non è stata immediata, malgrado tutto. Fra i displaced c’è chi ha trovato casa e lavoro senza troppi ostacoli, questo è vero, ma il peso della crisi, specialmente quando comincia a pesare e si diffonde, colpisce come sempre prima di tutto gli stranieri. E allora succede che nei campi profughi di Arbat, a 20 minuti da Sulaymaniyah – denominati Ashti 1 e Ashti 2, lungo la statale numero 4 che arriva al confine iraniano – le diverse appartenenze etnico-religiose finiscono per imporre il disegno di una geografica rigorosa, che vede sunniti, sciiti e yazidi sistemati in “quartieri” ben separati di un’immensa tendopoli, popolata da oltre 7 mila persone, in continua crescita. Un numero analogo di rifugiati, ma stavolta tutti siriani, si trova a poca distanza, ma sulla statale 46, subito dopo un bivio, nel campo di Barika.
Un numero di bambini piccoli incredibile. Nelle tre “città” fatte di tende, Emergency ha costruito altrettante cliniche “svizzere”, per la loro efficienza e pulizia. Una è interamente destinata alla pediatria, se non altro per il numero davvero impressionante di bambini piccoli e piccolissimi sui quali, le guerre irachena e siriana lascerà loro un debito da pagare che non sono in grado ora di immaginare. Il futuro ipotecato per una intera generazione, per la classe dirigente di domani, che non riesce ad andare a scuola se non in condizioni disgraziate, in mezzo alla polvere e a 45° all’ombra, oppure con il termometro sotto zero. E bambini ne continuano a nascere ogni giorno: “Non c’è una notte che qualcuno non mi chiami al telefono per informarmi di un parto, o per chiedere comunque un intervento a donne in gravidanza”, dice Attilia Serpelloni, responsabile medico.
Il lavoro dello staff medico infermieristico. L’assistenza sanitaria di Emergency ai profughi iracheni e siriani nei campi delle aree di Arbat, si confronta con bisogni urgenti ed enormi, come testimoniano i numeri forniti da Giacomo Menaldo, un giovane ingegnere a capo della missione, qui nell’area di Sulaymaniyah: “Una media di 1.600 persone a settimana nei centri sanitari di base nei tre campi per i rifugiati arrivati dalla Siria e per i profughi iracheni”. Ma lo staff medico-infermieristico ha attivato anche un programma di medicina preventiva ed educazione igienico-sanitaria destinata agli abitanti dei campi. La prevenzione, è evidente, ha molto a che fare con un’idea di futuro, al quale tutti – nonostante la guerra sia così vicina – continuano orgogliosamente a pensare.
(fonte: laRepubblica)